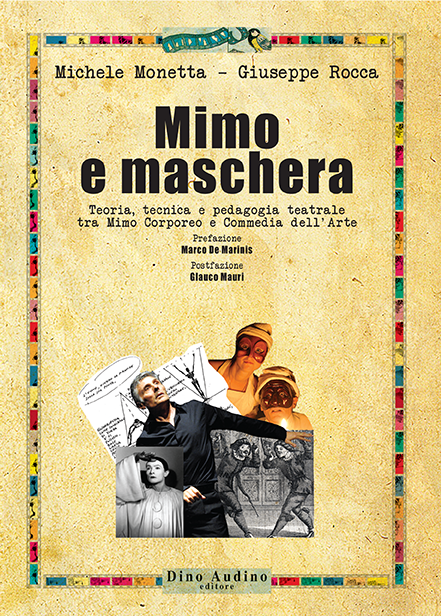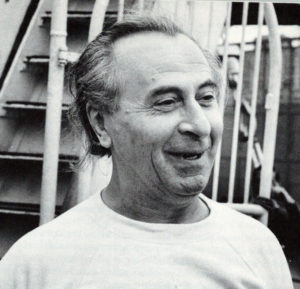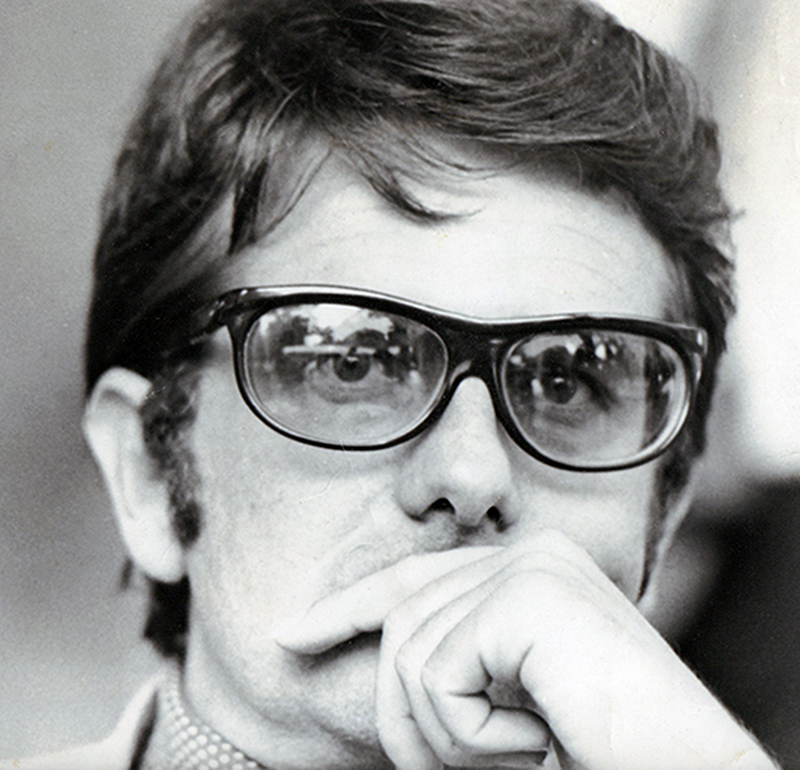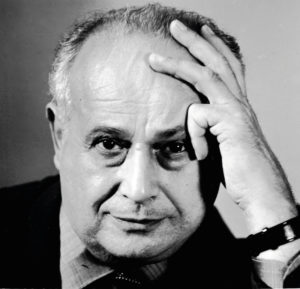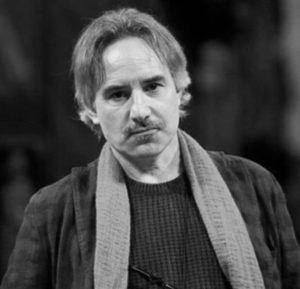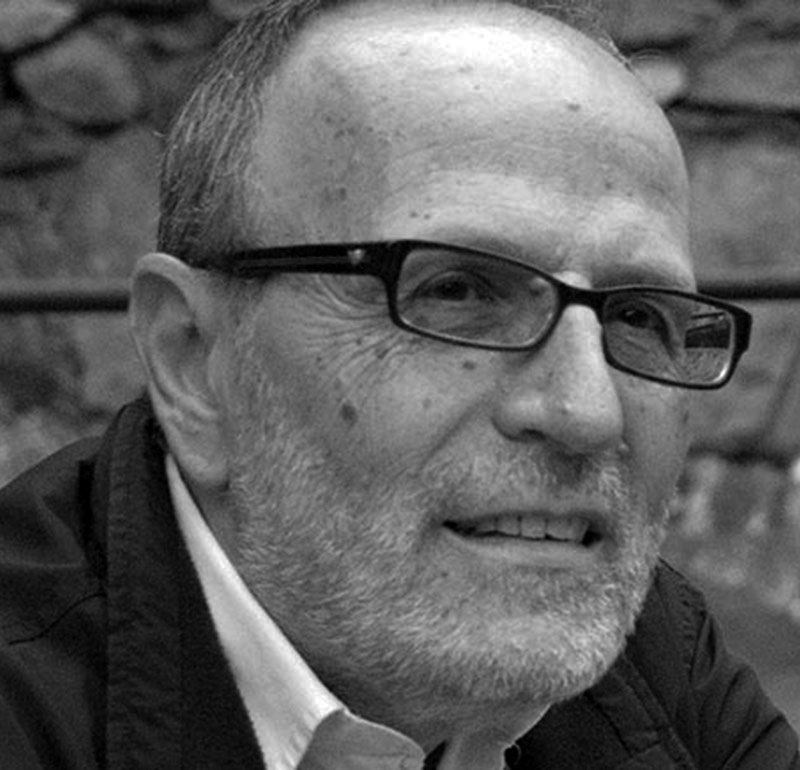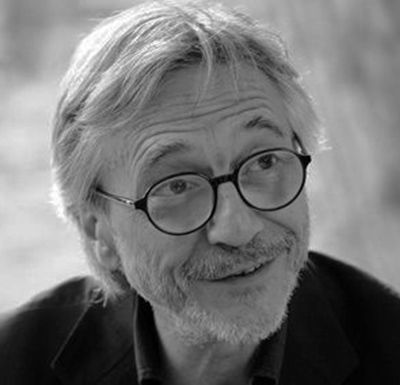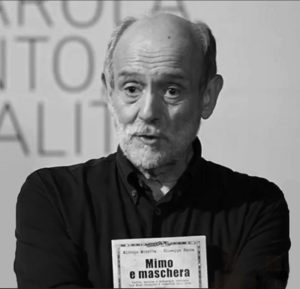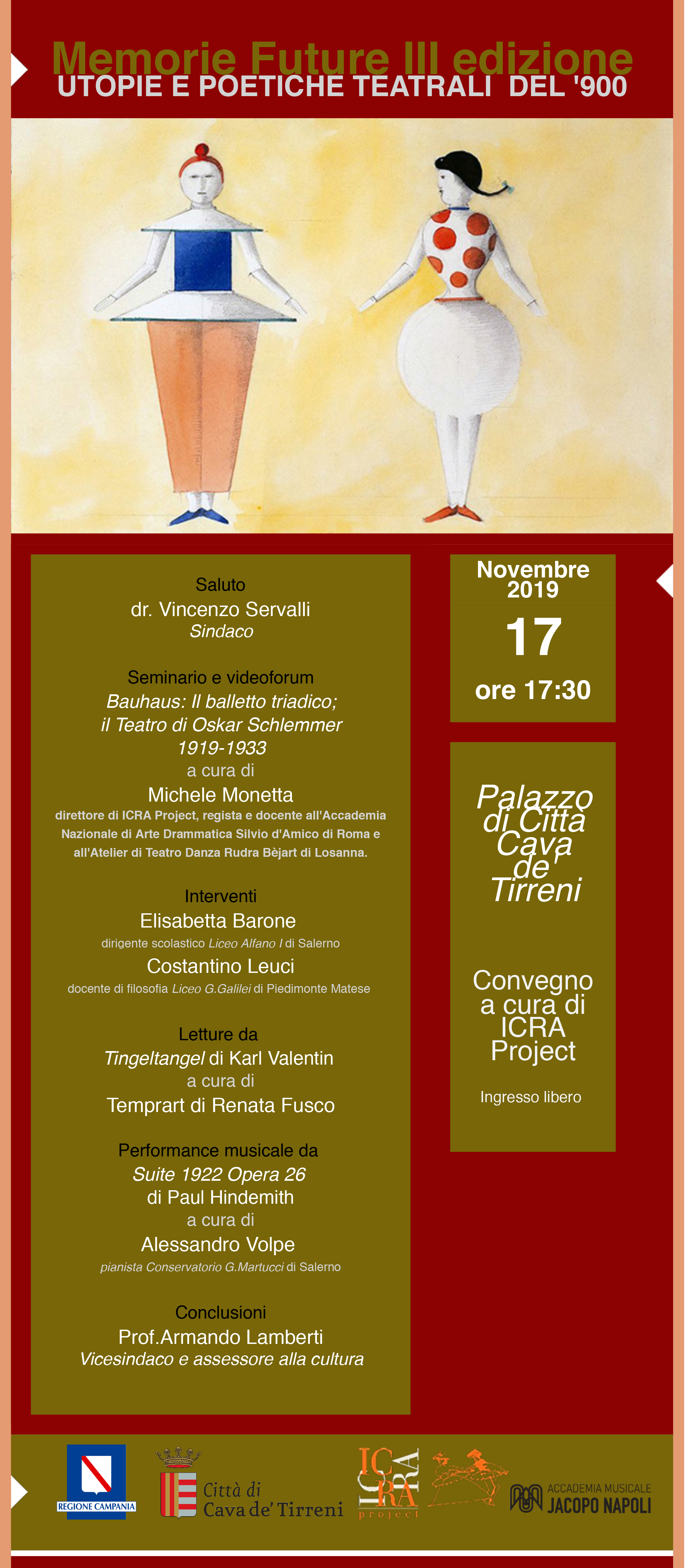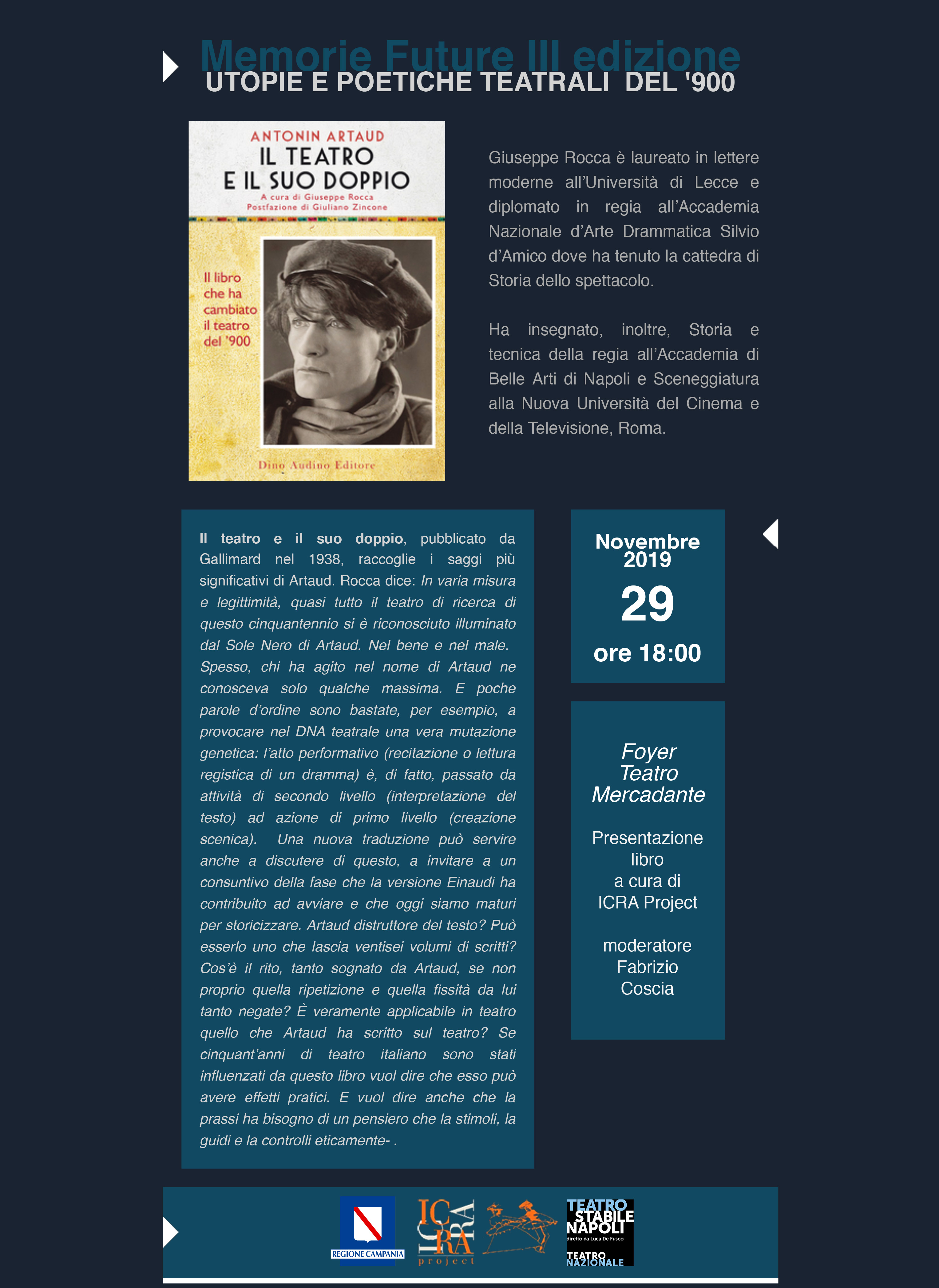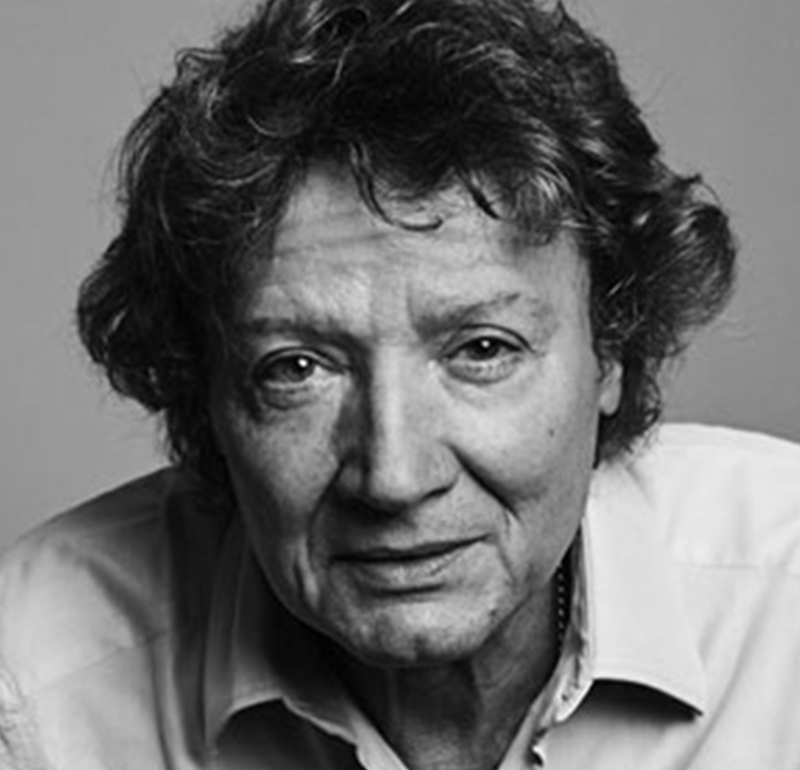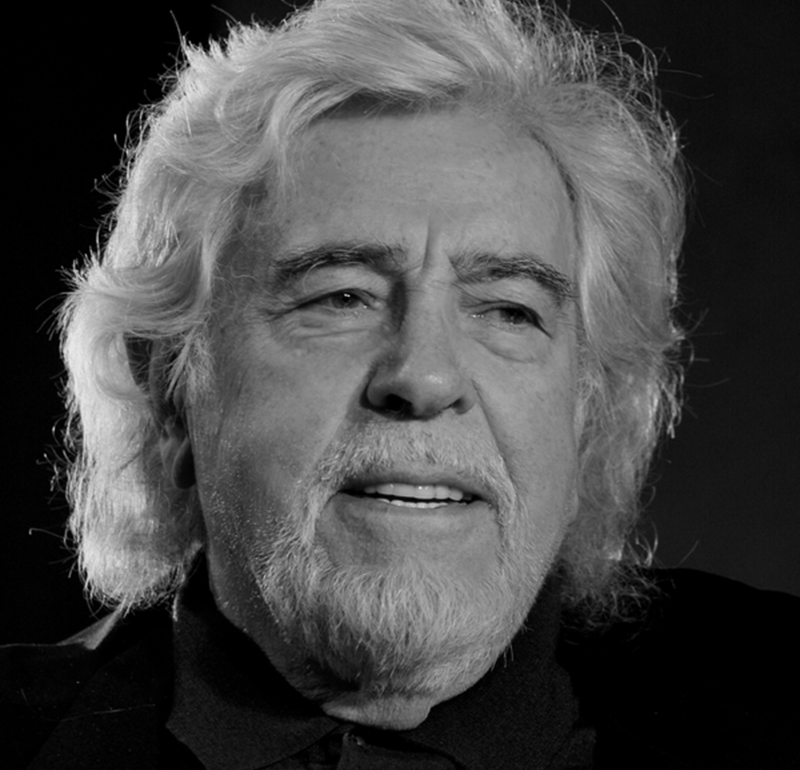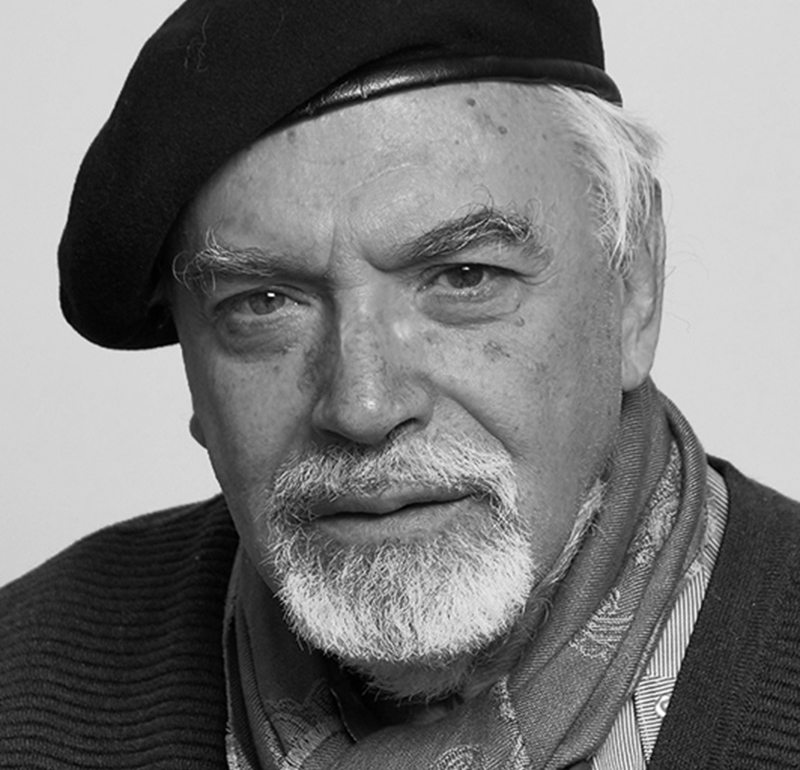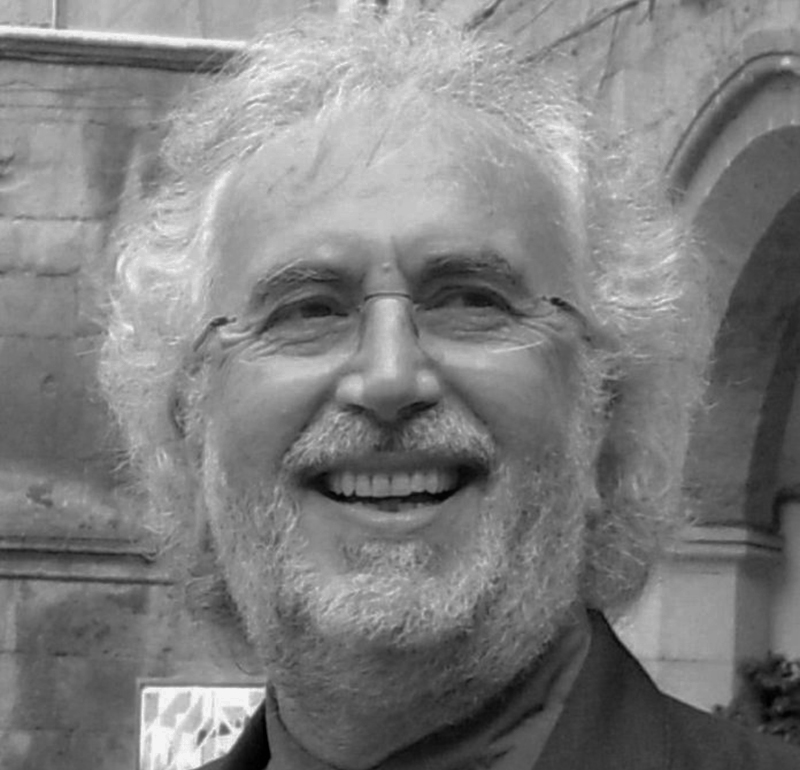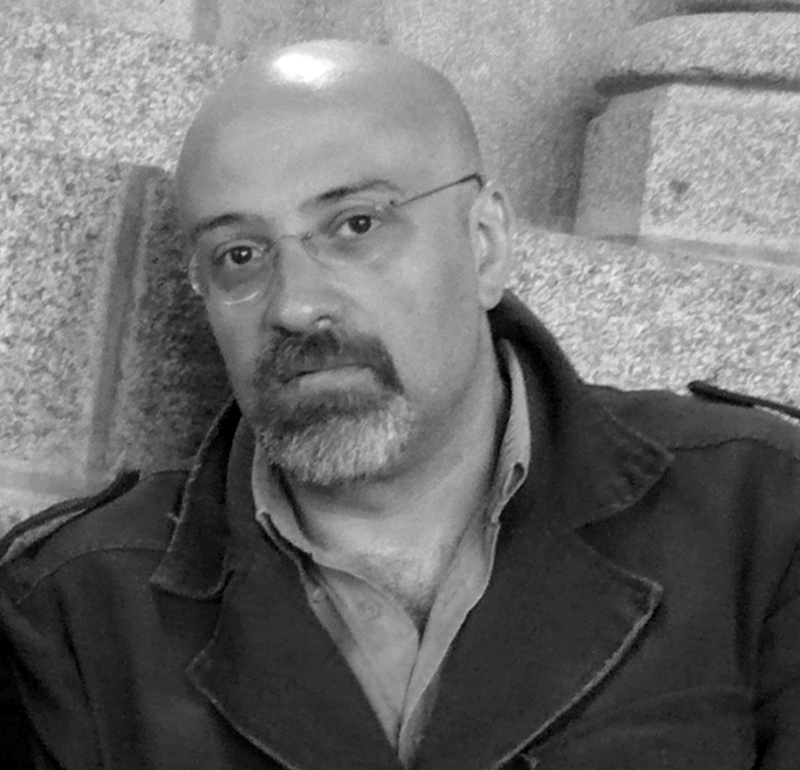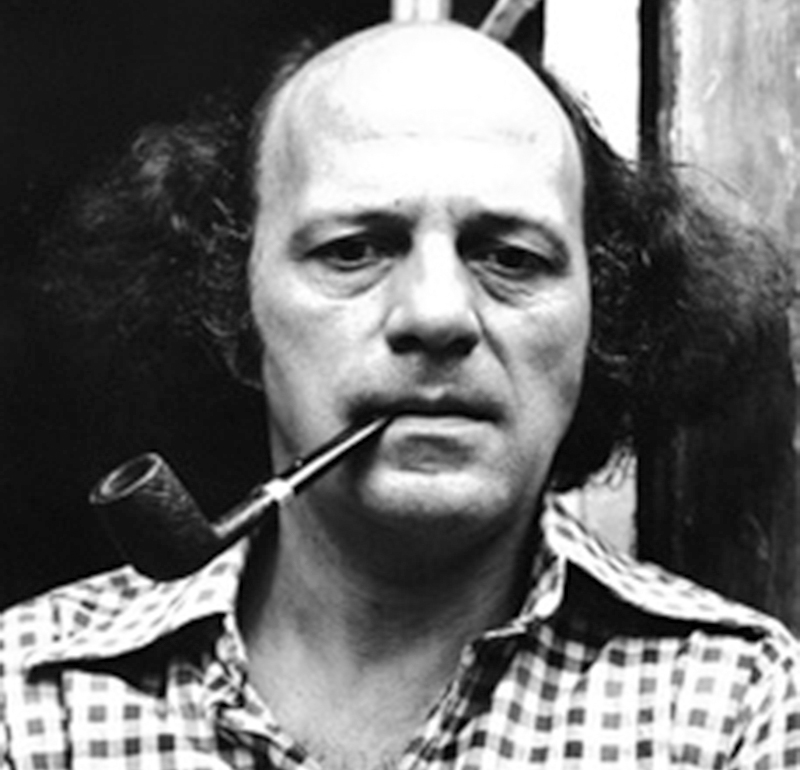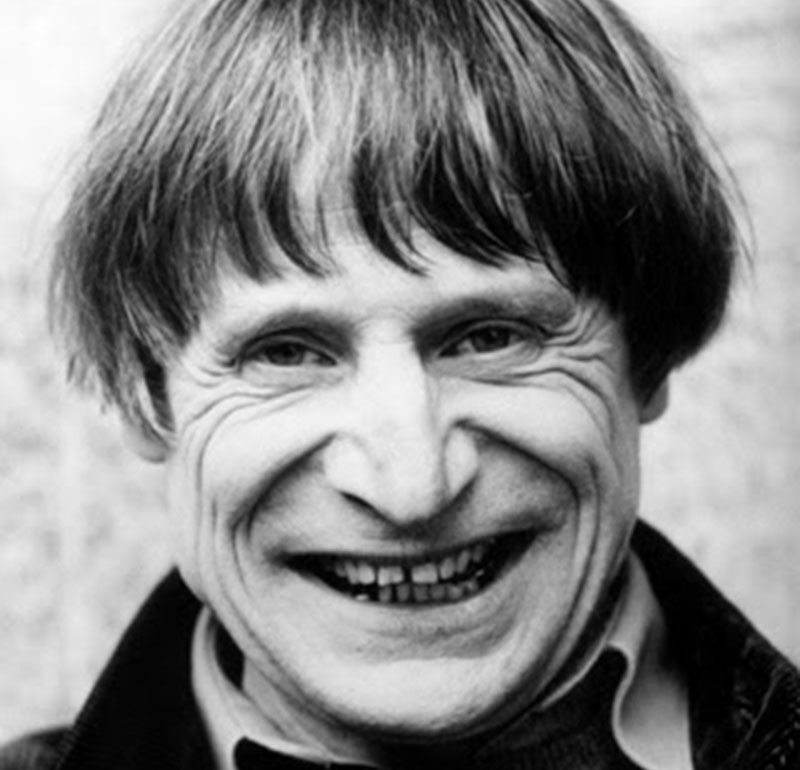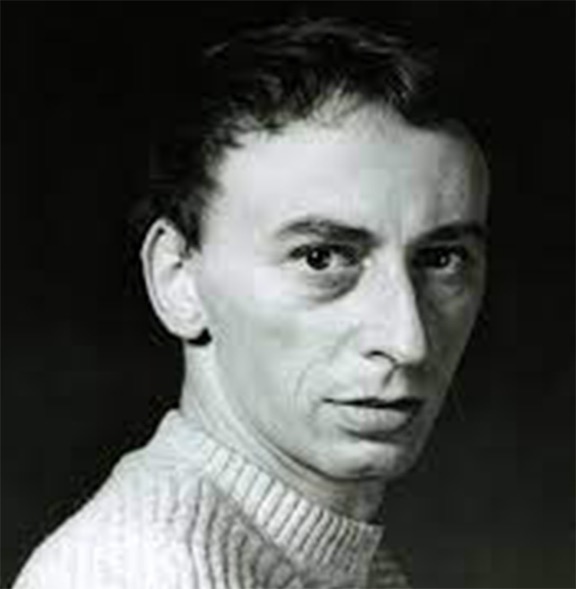ICRA PROJECT
centro internazionale
di ricerca sull'attore

La Storia

offerta formativa

Produzione
ICRA PROJECT
INTERNATIONAL CENTRE
FOR RESEARCH ON THE ACTOR

Our History

Training

Productions
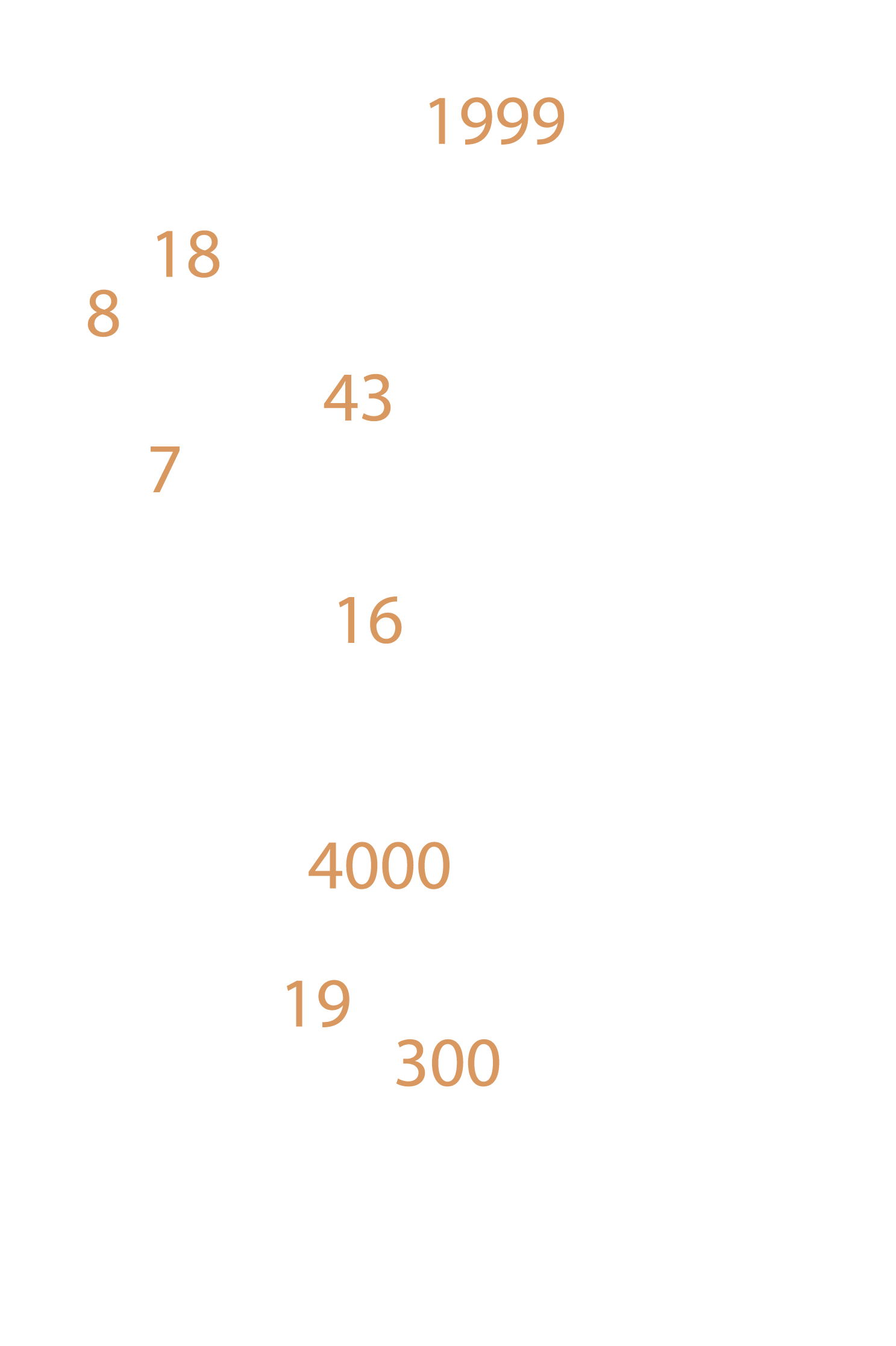
Nel 1994, i due direttori artistici, Michele Monetta e Lina Salvatore, tracciano le prime linee portanti dell'ICRA Project durante un master di Pedagogia Teatrale a Parigi con Monika Pagneux.
La creazione del Centro Internazionale di Ricerca sull'Attore che raccoglie, coordina e sviluppa attività nel campo del teatro, della musica, della pedagogia nell’arte drammatica e dei linguaggi multimediali, si concretizza poi nel 1999. I due direttori hanno alle spalle un lungo percorso di formazione e pratica teatrale di rilievo internazionale. Unendo il loro percorso formativo e la loro vasta esperienza teatrale nazionale e internazionale, coniugando percorsi differenti sviluppano così una pedagogia che coordina la ricerca, riguardante il movimento, che fa capo a maestri come Decroux, Feldenkrais, Lecoq, Gurdjieff.
Leggi tuttoMEMORIE FUTURE
Assemblea di Teatro fucina di incontri e confronti.
La conoscenza come memoria collettiva quale strumento di crescita, cambiamento e democrazia.
PREMIO DI PRODUZIONE SCARAMOUCHE
BANDO II EDIZIONE 2024
L’ICRA Project indice un bando per l’assegnazione di un premio di produzione rivolto a compagnie teatrali professionali. Il premio è promosso in collaborazione con la Coop. TeatroP e l’Assessorato alla Cultura di Lamezia Terme (CZ).
Invito alla presentazione di progetti teatrali
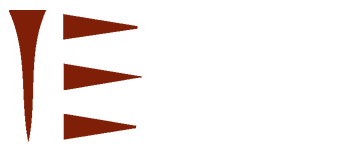
Un progetto di rete per la promozione teatrale nel Centro-Sud mirato al ricambio generazionale nel teatro e nello spettacolo; il progetto è stato approvato dal MiC Ministero della Cultura per il triennio 2022-2024. Partner: AIFAS San Benedetto del Tronto, TEATROP Lamezia Terme, HDUETEATRO Potenza, ONIRICA Bari, TEATRO ATLANTE Palermo. Leggi tutto
Mimo e Maschera
di Michele Monetta e Giuseppe Rocca
Teoria, tecnica e pedagogia teatrale tra Mimo Corporeo e Commedia dell'Arte
Prefazione
Marco De Marinis
Postfazione
Glauco Mauri
Editore Dino Audino
Masterclass
Teatro dell'assurdo
Settimana intensiva teorico-pratica per attori professionisti, registi e studenti di teatro su testi del Teatro dell'Assurdo in collaborazione con accademie d'arte drammatiche d'Europa.
Leggi tuttoMasterclass
Teatro elisabettiano
Settimana intensiva teorico-pratica per attori professionisti, registi e studenti di teatro su testi del Teatro elisabettiano in collaborazione con accademie d'arte drammatiche d'Europa.
Leggi tuttoMasterclass
Teatro russo
Settimana intensiva teorico-pratica per attori professionisti, registi e studenti di teatro su testi del Teatro russo.
Leggi tutto